Se lo scopo dell’arte è di rappresentare ciò che è ritenuto bello e il fine della scienza è di studiare ciò che è utile, allora l’anello di congiunzione si trova nella biologia, che in un concetto più ampio del semplice termine “studio della vita” diventa fonte di ispirazione per entrambe le discipline.
La biologia si basa su alcuni concetti fondamentali senza i quali è stato provato che non esisterebbe la vita; uno di questi è sorprendentemente la collaborazione di arte e scienza che gli studiosi definiscono “rapporto tra forma e funzione”: ogni cellula, tessuto ed organismo ha una struttura tale che il lavoro da compiere sia svolto nel modo più efficace possibile.
Il quam utillime soventemente si traduce in meravigliosi giochi geometrici; tra i quali il magister di tutti gli esempi è il frattale: si tratta di una replica perfettamente matematica che si ripete all’infinito all’interno della stessa compagine, dal macro al microscopico. Applicando la teoria alla pratica, Madre Natura ha creato i fiocchi di neve, emblema di tutti i frattali.
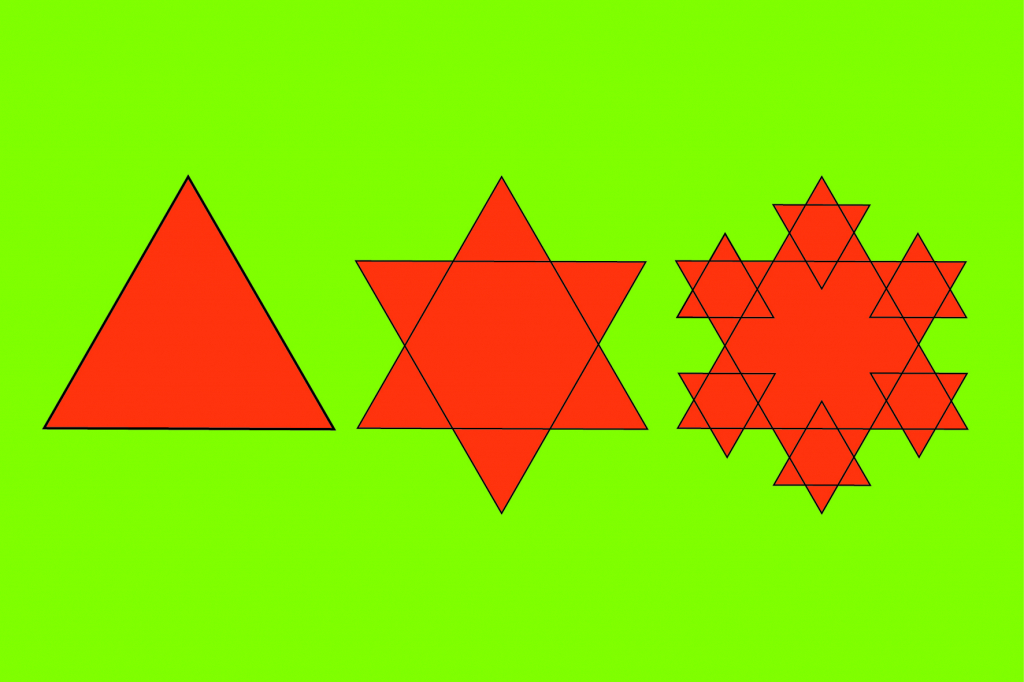
La biologia ha quindi sempre avuto un effluvio di richiamo per l’arte. D’altronde, come Democrito insegna, il simile riconosce il simile: ci si può riferire a periodi artistici ellenici come il Corinzio, con decorazioni per le colonne ispirate alle foglie, fino a giungere al XXI secolo con Christo e le sue sculture composte di soli elementi naturali.
La ricerca della perfezione si è anche sempre accompagnata al progresso scientifico esattamente come Keplero esplicita attraverso le sue leggi, o come ogni altro fisico tende a dimostrare: ogni fenomeno viene descritto con la semplice eccellenza di una formula per creare ordine all’interno di un più grande disordine composto dalle sconosciute leggi per gli avvenimenti ancora da scoprire.
In questo modo la scienza acquisisce un’altra sfumatura, perchè se prima si accompagnava all’arte, ora si trasforma essa stessa in attività volta al creare. Costruire una regolarità dove vi era una mescolanza diventa l’obiettivo dello studio.
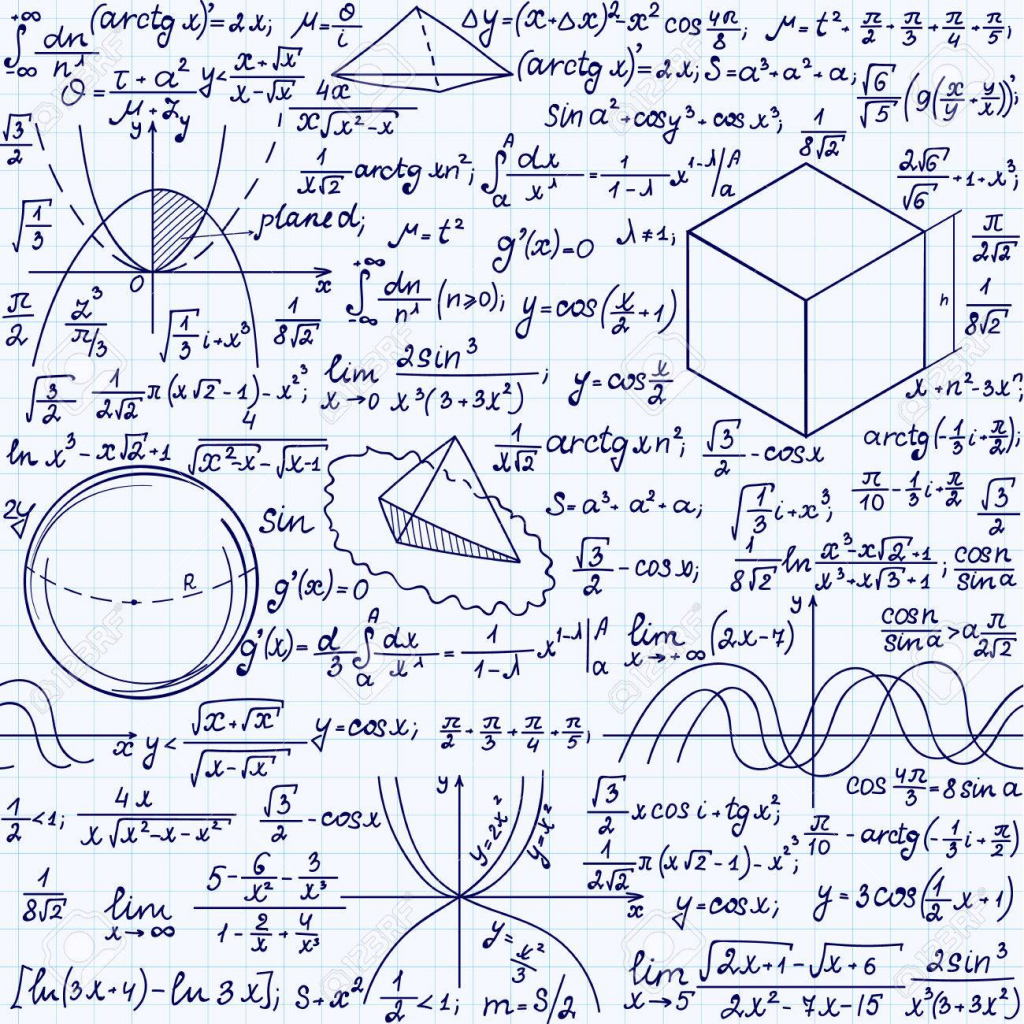
Meta ricercata fino dal IV secolo a.C. quando Socrate definì la felicità come puro “ordine dell’anima”.
Il premio Nobel Chandrasekar enuncia: “la bellezza che deriva dall’ordine armonioso (…) e che può essere colta da un’intelligenza pura”, attestando un’altra volta quanto il nostro cervello sia alla disperata ricerca di un fil rouge per collegare ogni aspetto dell’ambiente in cui è immerso, appunto un ordine esplicativo per tutti i fenomeni di cui è testimone.
La bellezza è quindi celata dietro allo schema caratteristico di ogni avvenimento suscettibile allo studio, la sfida si trova nel capire le regole del gioco che siamo soliti chiamare realtà, esiste una sola strategia: l’analisi della scienza.
